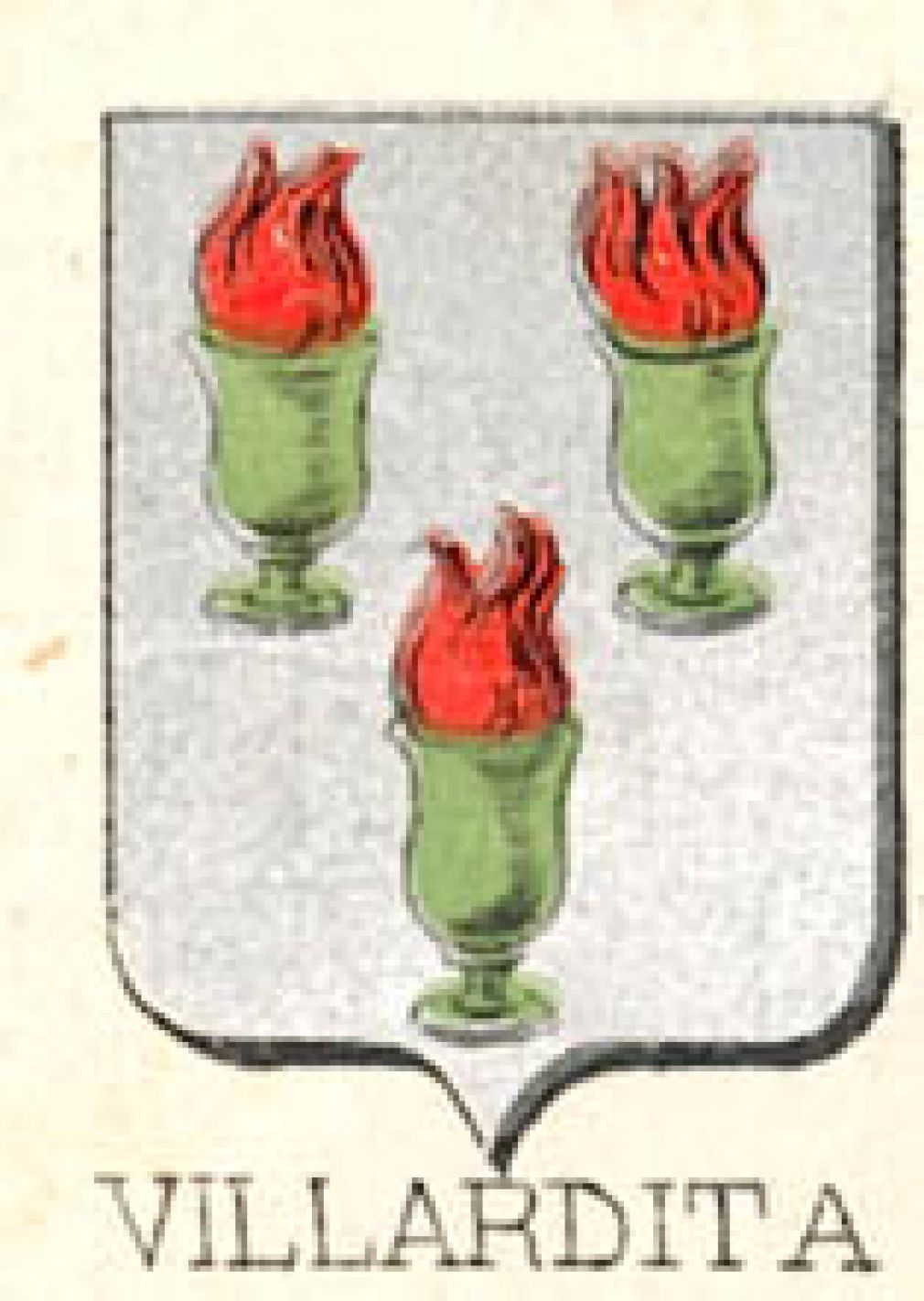|
| 'N Curiös â Tacùra |
Scritta in tempi non sospetti, la poetessa â ciaccësa Lucia Todaro mi fa gli auguri per l’anniversario del blog mandandomi questa poesia in lingua gallo-italica,
dedicata a quanti fanno della curiosità e della ricerca delle nostre “cose” uno dei motivi più gratificanti della propria vita.
Lucia, grazie infinite a nome mio e di tutti gli iscritti all’Accademia dei “Curiosi”
T’ VITTI
T’vitti…’ngiörn
ancora era matìngh…
annavi ddà
‘nte grötti a Dommartìngh…!
Nan m’ v’désti…
quant’eri stralunà
parràvi sö…
e l’ögg era v’trià…!
T’ vitti arrèra
stavota … a menzanöit
‘nvers â Tacura
e m’ parèvi cöit…
Unn’era a b’v’raùra
tu ggh’ f’rriàvi ‘ntönn
ciamann… fort l’egua:
ma nudd r’spunnëva…!
T’ vitti poi a s’ttèmbr…
nt’ ‘n giardìngh…
sëcca era a troffa…
e tu sempr m’schìngh’…
r’sc’dènn n’zzoli e cacch’rabò…
griàvi "Beddi d’ l’arma mia…
ora ggh’ vo’!"
Ma quau n’zzoli zerchi … ddascia stè…
nan vëdi ch’ unna vai ciù nan ggh’ n’è?
T’ vitti ancóra e ancora t’ vé
menz a ddi timpi timpi a zappuliè.
Chi speri d’ truvè marenghi e or?
o ch’ sötta u t’rréngh ggh’è u tr’sòr?!
Nan ggh’è ciù nent oramai d’ r’p’gghiè…
tutti cosi sp’rìnu… unna iè iè...
Cöddi spugghianu ‘nzìna l’ossi î morti…
e nudd po’ cuntè l’antica sorti…
Ora t’haia taccàt ed ê paròddi…
e vai sautànn ch’ par ch’avëssi i moddi!
Paròddi antichi… ’ntramàdi ‘ntê r’gordi…
cunzumàdi ‘ntê böcchi menzi torti…
dî végghi sgag’gghiàdi…
ch’ pass’nu giurnadi ntô bastiöngh
r’p’nzànn â l’grézza dâ Prima Cum’nióngh!
E cu l’aréggi avérti i vai ‘ncagghiànn
ment vanu p’ l’aria a svulazziànn:
una tâ sauvi zza unna ggh’è l’arma…
n autra tâ spuvrazzì e a ‘nciödi… anzi ch’ sparma…
e poi s’ perd quann ungh ‘ncav ggh’parra!
Ma chi poi fè cu sta parràda sbeuta
si tu…è n autr…è na faidda persa…?
Ma ora cré ch’ d’ ddà ncav… ‘ntô Cèlu,
‘ncorcùngh n’ disg cosi mai savùi…
e n’ fa sent u brì d’ spénz u vèlu
p’ canösc muménti scanusciùi…
ch’ autr nan ha s’ntùt a num’né….
E’ l’Angiuch’ t’ véd d’ ddà ‘ncàv
ch’ t’ talià d’figgh … d’ quann nan ggh’eri…
Cussà p’rchì s’ förma st’ m’sterì…
ch’ t’ fa sent u sciòr â V’r’tà !?
Lucia Todaro
Gaetano Masuzzo/cronarmerina