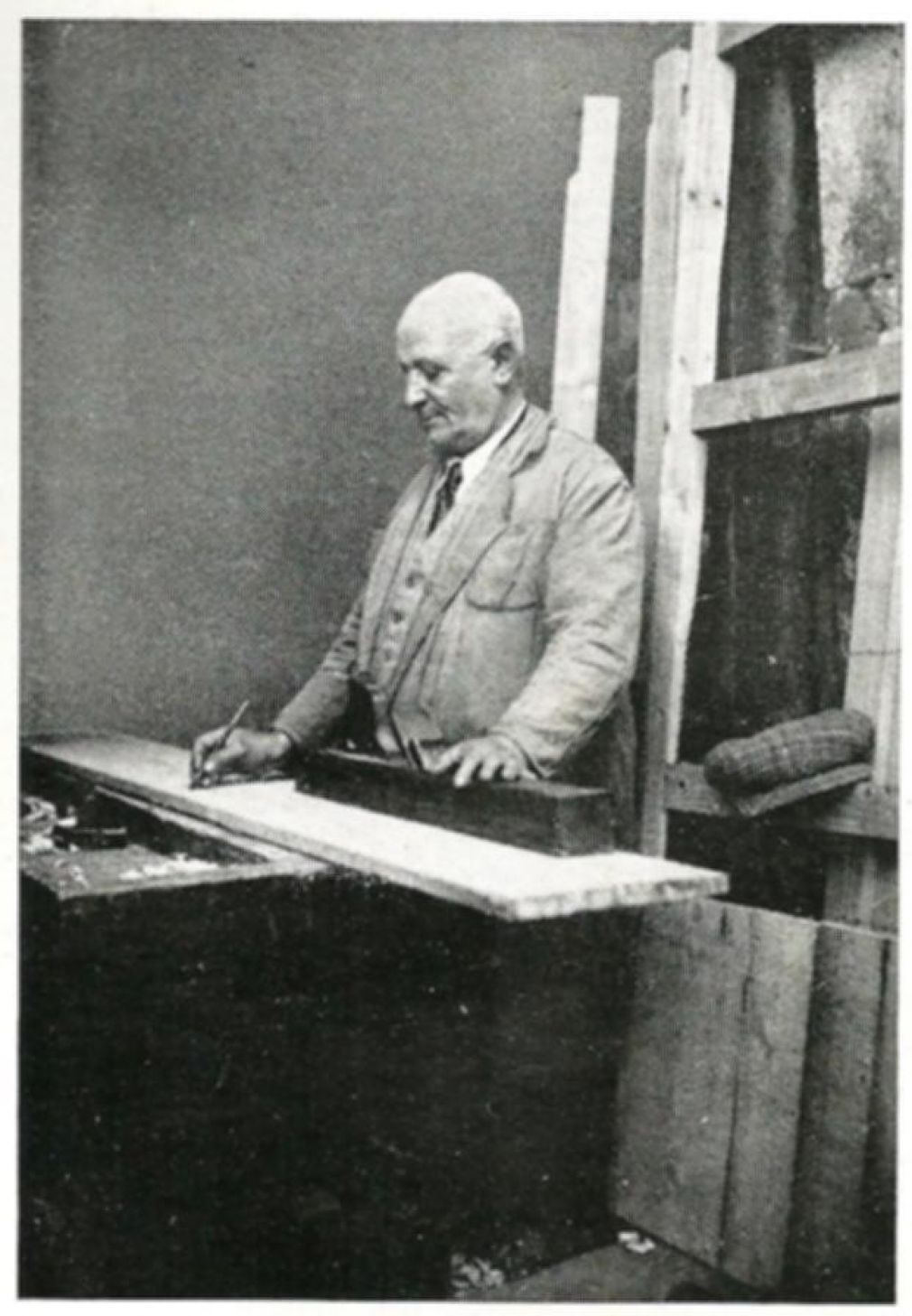|
| Di rosso a quattro pali d'oro attraversato da una banda d'azzurro |
La famiglia Paternò discende dalla Casa Sovrana dei Conti di Barcellona e Provenza e da quella Sovrana degli Altavilla. Il suo capostipite è Roberto d'Embrun (1050-1085 ca., il cui stemma è come quello della Casa Sovrana di Barcellona) che nel 1070 segue il Gran Conte Ruggero in Sicilia e per aver conquistato la cittadina di Paternò, ne assume la signoria feudale e il cognome, oltre ai feudi e casali di Buccheri e di Aylbacar. Dal XIII sec. i Paternò sono insigniti di un vasto numero di baronie e dall'inizio del '600 anche di titoli principeschi e ducali. Nel nostro territorio i Paternò sono presenti dai primi decenni del '400 in tre feudi: Imbaccari, Raddusa e Spedalotto.
Paternò di Imbaccari Sottano
Il feudo di Imbaccari Sottano è posseduto dal 1424 da Gualtiero de Paternò, nel 1503 da Francesco Paternò e nel 1520 da Blandinello Paternò. Nel 1579 se ne investe Giuseppe Paternò insieme al feudo di Baldo e di Piana di Minnelli (pertinenze di Imbaccari) e nel 1585 vende Imbaccari Sottano alla famiglia Gaffori. Nel 1610 ottiene per Baldo la "licentia populandi" dandogli il nome di Mirabella, in onore della famiglia Mirabella alla quale appartiene la moglie Eleonora. Nel 1624 Giacinto succede al padre Giuseppe e decide di trasferire il nuovo borgo dal feudo di Baldo a quello più in alto di Imbaccari Sottano, per problemi climatici e ambientali. Dopo aver iniziato la costruzione nel nuovo sito nel 1630, acquista definitivamente Imbaccari Sottano dai Gaffori e col comune di Platia chiude la vertenza nel 1635 pagando 200 onze. Nel 1650 ca. eredita i feudi il nipote Gualtiero e poi i figli di questo, Giuseppe e Francesco Maria. Quest'ultimo, senza figli, vende Imbaccari Sottano e Terra di Mirabella a Trigona Luigi nel 1693 e Baldo al fratello Geronimo Paternò nel 1714. Quest'ultimo, nel 1730, dopo aver recuperato Imbaccari Sottano e Terra di Mirabella nel 1734 vende tutti i 3 feudi a Vincenzo Paternò Castello principe di Biscari (l'investitura è del 1737). Alla sua morte, nel 1739, i feudi passano al suo primogenito, Ignazio Paternò Castello Scammacca principe di Biscari detto il Grande. L'ultimo della famiglia Paternò Castello che erediterà i beni di Mirabella nel 1897 è Ignazio, che frazionerà il feudo in piccoli appezzamenti e donerà sia il Palazzo baronale (1928) che il terreno per la costruzione delle Scuole Elementari (1930), prima di entrare tra i Chierici Regolari di S. Paolo detti PP. Barnabiti.
Paternò di Raddusa e Imbaccari Sottano
Nel 1503 Francesco Paternò, barone di Imbaccari Sottano, si investe anche del feudo di Raddusa. A Francesco succede Giacinto. Il secondogenito di questi, Vincenzo Maria Paternò Celestri, illustre cittadino piazzese, professore di diritto presso l'Univ. di Catania e Giudice della Gran Corte Civile del Regno, prima acquista nel 1648 il feudo di Recalcaccia e poi riceve nel 1656, dal nipote Gualtiero Paternò, i feudi di Raddusa e Destra. Rimasto vedovo si fa prete e lascia al figlio Giacinto il feudo Recalcaccia e all'altro, Francesco Maria, Raddusa e Destra. Quest'ultimo si sposa con Silvia Trigona dei baroni di Spedalotto e lascia al figlio, Vincenzo Paternò Trigona, Raddusa e Destra dei quali ne risulta barone nel 1713. Dagli sposi Francesco Maria e Silvia Trigona derivano, dopo oltre un secolo, i Paternò di Spedalotto. Ritornando a Giacinto, barone di Recalcaccia o Spinagallo (SR), questi ha una figlia, Eleonora, che sposa Ignazio Paternò Castello principe di Biscari. Il loro primo figlio Vincenzo, nel 1713, risulta barone di Raddusa e Destra. Dopo circa ottant'anni, nel 1790, Vincenzo Maria Paternò è barone di Raddusa e Destra.
Paternò di Spedalotto
1790 Onofrio Paternò è barone di Spedalotto, Gallitano, Alzacuda e Sofiana. 1838 Emanuele Paternò Ventimiglia è marchese di Spedalotto e nel 1848 diventa ministro nel governo siciliano indipendente di Ruggero Settimo. Sempre nel 1848 Vincenzo Paternò Trigona è marchese di Spedalotto e pretore di Palermo e fa parte del Comitato Generale della Rivoluzione.
Gaetano Masuzzo/cronarmerina